La Legge Merlin e l’addio alle Case di Tolleranza
- Tacus Associazione
- 19 feb 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Nel febbraio del 1958, quando Lina Merlin – donna minuta e ostinata, socialista per convinzione e non per opportunità, irriducibile nelle sue battaglie – vide finalmente approvata, dopo quasi un decennio di scontri parlamentari e resistenze culturali, la legge che porta il suo nome, l’Italia non firmò soltanto l’atto di nascita di una nuova disposizione legislativa, ma sancì la rottura di un patto silenzioso, sedimentato negli anni, tra lo Stato e la collettività. Un patto che aveva consentito di relegare la prostituzione dietro porte discrete e vetri smerigliati, in quegli edifici che si dischiudevano soltanto a chi sapeva esattamente perché bussava e che appartenevano più alla geografia morale che a quella urbana.
Era l’Italia che avanzava verso il boom economico, che tentava di scrollarsi di dosso le macerie della guerra e di un regime; che affrontava il dibattito pubblico attraverso la morale cattolica e la retorica patriarcale, dove la donna era considerata più attraverso il suo ruolo di moglie e di madre che di cittadina.
In tale contesto, la chiusura delle case di tolleranza, più che un provvedimento amministrativo, fu una dichiarazione politica e, soprattutto, culturale, affermando che i principi della Costituzione repubblicana – con il loro richiamo alla pari dignità e alla libertà personale – non erano mera retorica, ma architravi di un nuovo ordine civile.
Il quadro normativo pre-1958
Prima della Legge Merlin, l’ordinamento italiano respirava secondo il ritmo di un modello regolamentarista ereditato dalla Francia napoleonica e consolidato nel XIX secolo. Le cosiddette case chiuse – un’espressione popolare che ne sintetizzava la clausura – erano esercizi legalmente autorizzati, sorvegliati dalla pubblica sicurezza e sottoposti a controlli sanitari che, pur presentandosi come presidio di igiene collettiva, finivano per trasformarsi in strumenti di sorveglianza e di controllo sociale.
Le donne, spesso giovanissime e provenienti da contesti di miseria assoluta, venivano registrate in questura, sottoposte a visite ginecologiche periodiche e vincolate a rigide regole che ne limitavano la libertà di movimento: adescare un cliente o uscire senza autorizzazione, poteva significare perdere il diritto di esercitare in quel “mondo protetto” ma chiuso come una prigione.
Era un sistema che, mentre proclamava di proteggere la salute pubblica e di contenere le malattie veneree – ossessione di un’epoca che temeva più il contagio morale che quello fisico – istituzionalizzava, di fatto, una discriminazione giuridica. Molti scrittori hanno lasciato ritratti che oscillano tra il pittoresco e il tragico: nei loro racconti si respirano l’odore acre del disinfettante, il dolciastro dei profumi pesanti, il silenzio dei corridoi dove l’eco dei passi dei clienti suona come un richiamo rituale.
La Legge Merlin: finalità e contenuto normativo
Con la legge n. 75 del 20 febbraio 1958, lo Stato italiano abbandonò il regolamentarismo per abbracciare una prospettiva abolizionista: le case di tolleranza furono chiuse senza eccezioni, le schedature abolite, le visite obbligatorie cancellate, e vennero introdotte pene severe contro chiunque favorisse, inducesse o traesse profitto dalla prostituzione altrui.
Lina Merlin, in un discorso che oggi potremmo definire tanto giuridico quanto morale, chiarì che la legge non intendeva perseguitare le donne – la prostituzione individuale non veniva infatti criminalizzata – ma eliminare le condizioni legali e materiali che rendevano possibile un loro sfruttamento legalizzato. Era, nelle sue parole, un atto di “riparazione” verso chi era stata ridotta a merce sessuale sotto il beneplacito dello Stato.

Implicazioni giuridiche
Il nuovo impianto normativo demolì un edificio giuridico radicato da oltre un secolo.
Il passaggio dal controllo amministrativo alla repressione penale degli sfruttatori non fu soltanto un mutamento tecnico, ma una ridefinizione del rapporto tra diritto e morale pubblica. Tuttavia, la legge lasciò scoperta un’intera area di intervento sociale: mancarono strutture di accoglienza, programmi di reinserimento e sostegni economici.
Il risultato fu che la prostituzione, privata delle sue mura di contenimento, si riversò per strada o in appartamenti privati, rendendo più difficile il monitoraggio sanitario e offrendo terreno fertile alla criminalità organizzata. Alcuni giuristi, già negli anni Sessanta, avvertirono che il passaggio da una regolamentazione controllata a un’abolizione senza rete avrebbe comportato conseguenze inattese.
Implicazioni socio-culturali
La legge Merlin fu anche un atto simbolico: dichiarò la fine di un’istituzione che, pur avvolta nel riserbo e celata da facciate borghesi, era profondamente radicata nella mentalità maschile come un’infrastruttura sociale silenziosa. La letteratura italiana del primo Novecento non mancherà di alludere a queste case come luoghi d’iniziazione virile o di sollievo coniugale.
L’abolizione tolse alla società la possibilità di fingere che la prostituzione fosse un fenomeno circoscritto e innocuo. Costrinse lo sguardo collettivo ad affrontare ciò che, fino a quel momento, era stato relegato nell’ombra. Non stupisce, dunque, che la riforma divise l’opinione pubblica: per alcuni fu un passo di civiltà, per altri un gesto ingenuo che avrebbe soltanto spostato il problema dalla porta socchiusa al marciapiede.
Critiche e dibattito
Il dibattito, acceso allora e mai sopito, si polarizzò presto. Da una parte, i fautori dell’abolizionismo sostenevano che la dignità della persona non può essere oggetto di contrattazione, e che lo Stato non deve – e non può – essere complice nella mercificazione del corpo umano. Dall’altra, i sostenitori di una regolamentazione invocavano il pragmatismo: la gestione pubblica della prostituzione, dicevano, garantirebbe controllo sanitario e sicurezza.
Già negli anni Sessanta, voci autorevoli denunciarono che la chiusura delle case aveva reso le donne più vulnerabili alla violenza di strada e al ricatto della criminalità. E se ancora oggi in Italia si discute se riaprire o meno alla regolamentazione, è perché il nodo di fondo – il rapporto tra libertà individuale, morale pubblica e ordine sociale – non ha mai trovato una risposta definitiva.
L’eredità ambivalente della Legge Merlin
A oltre sessant’anni dalla sua approvazione, la Legge Merlin resta una pietra miliare del diritto italiano e della storia culturale del Paese. Fu un atto di rottura in un’Italia sospesa tra la tradizione patriarcale e le aspirazioni democratiche, e fu anche un gesto di coraggio politico raro. Ma, come scrisse Pier Paolo Pasolini, “la realtà è sempre più forte delle leggi, anche se le leggi possono cambiare la coscienza della realtà”: la riforma non cancellò la prostituzione, ma ne mutò per sempre il volto e il posto nell’immaginario collettivo.
Forse è proprio in questa ambivalenza – tra vittoria morale e fragilità pratica – che si nasconde il significato più profondo della legge: aver costretto il Paese a guardare in faccia una verità che per troppo tempo aveva preferito nascondere dietro un vetro smerigliato.
Se vuoi approfondire la tematica e scoprire dal vivo storie, luoghi e protagonisti di un capitolo affascinante e controverso della storia cittadina, partecipa al tour Palermo a Luci Rosse. Eros, virtù, peccati e case chiuse: un itinerario storico-antropologico tra memorie di bordelli, curiosità, aneddoti e retroscena legati alla Legge Merlin e alla prostituzione a Palermo.
Crediti
Testo a cura di TACUS Arte Integrazione Cultura - Associazione di promozione sociale.
Immagini elaborate con intelligenza artificiale OpenAI.
Ricerca storica e culturale condotta su fonti bibliografiche e documentarie.


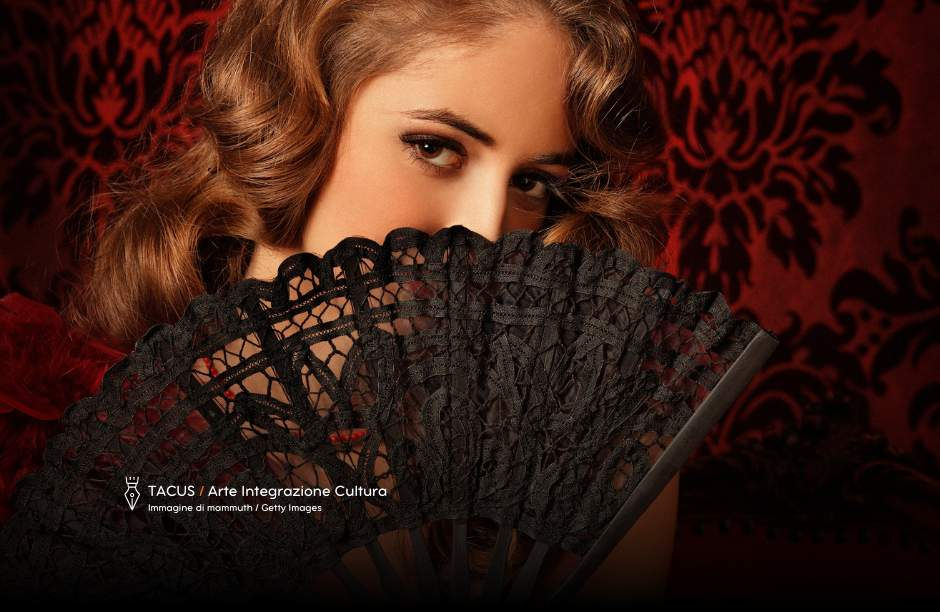
Commenti